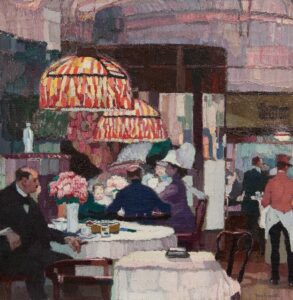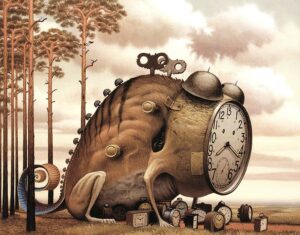La Corte di merito aveva liquidato la somma del risarcimento, specificando trattarsi già di somme “all’attualità” e riconoscendo anche gli interessi compensativi secondo i criteri fissati da Cass. Sez. U. n. 1712 del 1995. Quindi si era limitata a stabilire che andavano detratti gli importi già versati nel corso del precedente giudizio. Non avendo specificato le modalità di calcolo, tale statuizione non poteva che essere interpretata nel senso di legittimare una mera aritmetica sottrazione, dall’importo risarcitorio liquidato “all’attualità” e quindi rivalutato, dell’importo o degli importi nominali degli acconti, senza tener conto delle date in cui essi sono intervenuti e del loro effettivo valore monetario, così in definitiva contrapponendo valori non omogenei.
La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa in data 28 aprile 2025 n. 11172, rileva la violazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che ribadisce, “secondo cui nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento “va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
b) detrarre l’acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (v. ex multis Cass. n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854; n. 16027 del 18/05/2022, Rv. 664900-01; n. 23927 del 07/08/2023, Rv. 668474-01)“
Pur consapevole del differente orientamento da parte della Corte di Cassazione in ordine alla presunta non applicabilità dell’art. 1194 c.c.(implicitamente confermata anche dalla presente decisione), si rammenta comunque una precedente posizione della medesima Corte (Cass. Civ. 23 febbraio 2005 n. 3748), secondo la quale l’art.1194 c.c “contempla un’ipotesi di pagamento parziale, essendo il debito, avente per oggetto il capitale e gli interessi, un debito unico, come risulta dall’art.1208 n.3 C.c. La norma fa dunque riferimento al caso in cui il creditore accetta un pagamento parziale che potrebbe legittimamente rifiutare, ed è a favore del medesimo creditore il quale, se fosse costretto a subire anche la diversa imputazione operata dal debitore, perderebbe il beneficio dell’ulteriore fruttificazione del proprio capitale. Ciò premesso, nessuna valida ragione può indurre a rinvenire il presupposto applicativo della norma nella contemporanea liquidità del credito per capitale e del credito per accessori, sia perché nulla di simile si arguisce dalla lettera della disposizione, la quale non prescrive quel speciale requisito; sia perché, essendo la stessa, come si è detto, posta a tutela dell’interesse del creditore, non si vede perché questi, solo perché il suo credito risarcitorio è, per definizione, e non per sua colpa, illiquido fino alla sentenza che lo traduce in credito pecuniario, dovrebbe trovarsi svantaggiato rispetto al creditore di una somma immediatamente liquida, tanto per il capitale quanto per gli accessori. Del resto, a conferma dell’applicabilità dell’art.1194 C.c., dettato per i debiti fruttiferi, anche il debito risarcitorio è per natura fruttifero, a decorrere dal dì del fatto dannoso, a prescindere dalla mora e dalla liquidità; ed anzi, nell’illecito aquiliano, gli interessi, definiti perciò compensativi, assurgono a componente del debito, destinati come sono a compensare il creditore danneggiato del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione. L’unica differenza, non decisiva, rispetto al caso ordinario del debito liquido per capitale e accessori, è che l’imputazione sarà rinviata al momento in cui sarà nota la somma definitivamente liquidata, e, con essa, sarà possibile il calcolo esatto dell’eventuale residuo dovuto”.
La questione dovrebbe essere affrontata in maniera più approfondita?