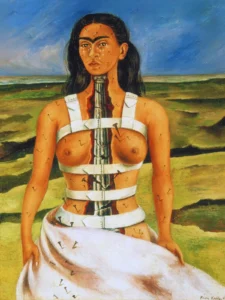La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13518 del 20 maggio 2025, in tema di illegittimo diniego della portabilità del numero dell’utenza telefonica, ha rilevato che: “vanno tenute invero in considerazione tutte le ripercussioni -patrimoniali e non patrimoniali – negative subite dall’utente creditore in conseguenza dell’inutilizzabilità nella specie della specifica utenza telefonica de qua, dovendosi al riguardo invero prescindere dall’eventuale sussistenza di mezzi alternativi estranei al rapporto contrattuale in argomento, come tali pertanto del tutto irrilevanti.
Quanto al danno patrimoniale, che può essere provato nell’an anche per presunzioni (v., da ultimo, Cass., 13/11/2024, n. 29252; Cass., 12/7/2023, n. 19922), anche relativamente alla sussistenza di prova del nesso causale tra condotta e perdita (cfr., da ultimo, Cass., 5/9/2023, n. 25910), questa Corte ha già avuto modo di affermare che il relativo ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,1224,1225,1225,1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio la medesima consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352); esso deve essere pertanto determinato in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (non essendo previsto l’arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all’altro: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 8/2/2012, n. 1781), venendo dunque in rilievo il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814). Atteso che di alcuni aspetti o voci del danno patrimoniale (es., il danno patrimoniale futuro e il danno da perdita di chance) la valutazione non può invero essere che equitativa (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211. E, da ultimo, Cass., 5/9/2023, n. 25910; Cass., 12/7/2023, n. 19922), ad essa il giudice del merito deve fare ricorso -anche d’ufficio in assenza di domanda di parte-, e pure in grado di appello, in ipotesi di estrema o particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831), ferma restando la necessità di riferirsi all’integralità dei pregiudizi accertati (v. Cass., 6/12/2018, n. 31546).
Per altro verso, si è da questa Corte precisato che allorquando l’inadempimento dell’obbligazione determini anche un danno non patrimoniale, la domanda di relativo ristoro può essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni, in quanto gli interessi di natura non patrimoniale ben possono assumere rilevanza nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, atteso che ai sensi dell’art. 1174 c.c. la prestazione oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973). In caso di danno non patrimoniale, debbono essere risarcite le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano nella “doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza” (Cass. 17/1/2018, n. 901), la cui prova, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti” (Sez. U, Ordinanza n. 5992 del 6/3/2025). Diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può infatti mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene la relativa valutazione necessariamente equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). Valutazione equitativa che è diretta a determinare “la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa” (in ordine al significato che nel caso assume l’equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).
Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo, e non meramente eventuale o ipotetico (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536), nonché alla circostanza dell’impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all’individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell’onere probatorio imposto all’art. 2697 c.c.: v. Cass., 4/11/2014, n 23425; Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. In tema di liquidazione del danno l’equità si è da questa Corte intesa nel significato di adeguatezza e di proporzione, assolvendo alla fondamentale funzione di “garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle “disparità di trattamento” e delle “ingiustizie” (cfr. in tali termini Cass., 7/6/2011, n. 12408). I criteri da adottarsi al riguardo (tra cui debbono considerarsi utilizzabili anche quelli dettati in tema di indennizzi dal Regolamento AGCOM n. 73/11/CONS), la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire di addivenire ad una liquidazione che sia equa e congrua. Per essere equa, la quantificazione del danno deve essere adeguata e proporzionata (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitone (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 23/1/2014, n. 1361). Atteso che il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato/creditore non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento a lui causalmente ascrivibile (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645), in caso di valutazione equitativa deve tenersi conto che per essere congrua, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale, la quantificazione del ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento (cfr., con riferimento al danno non patrimoniale, Cass., 23/1/2014, n. 1361). Nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice deve allora garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell’integralità del ristoro nei suesposti termini, sia sotto il profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui le categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale rispettivamente si scandiscono nel singolo caso concreto (v., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12211), sia avuto riguardo alla congruità della relativa quantificazione. Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, non può essere infatti liquidato in termini né puramente simbolici o irrisori né comunque non correlati all’effettiva natura o entità del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere determinato in ammontare equo e congruo (v., in particolare, Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 14/7/2015, n. 14645)“