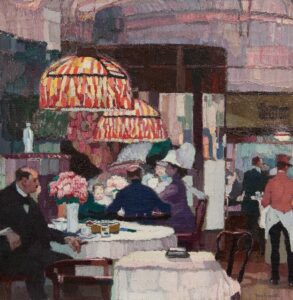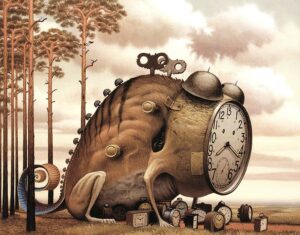La Corte di Cassazione (sentenza del 10 luglio 2025 n. n.18958 – dott. Roberto Simone) censura la sentenza della Corte di merito, in merito ad un incidente nautico, rilevando che sono stati invertiti i termini dell’apprezzamento delle condotte del pilota del gommone e del soggetto trasportato, per essere stata valutata esclusivamente quest’ultima prescindendo del tutto dalla prima. In particolare espone che: “la Corte d’Appello non avrebbe potuto apprezzare il concorso di colposo della trasportata senza prima valutare la condotta del pilota del gommone, il cui esame è stato limitato al solo fine di escludere che l’evento sia stata la conseguenza diretta ed esclusiva della riferita manovra, o “finanche mancata riduzione della velocità da parte del conducente del natante”, ostandovi il contenuto dell’art. 40 D.Lgs. 171/2005 (“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”). Norma, quest’ultima, stabilente che “La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall’articolo 3, è regolata dall’articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo 2947, comma 2, dello stesso codice”.
Il Collegio precisa che: “tale disposizione si applica al caso in esame, posto che il gommone della lunghezza di otto metri deve considerarsi alla stregua di “natante da diporto” in base all’art. 1, lett. g), D.Lgs. 171/2005 per avere uno scafo lungo meno di dieci metri. Infatti, come è stato affermato da questa Corte, il cui indirizzo deve essere confermato in questa sede, tra la normativa sulla navigazione da diporto (a fini sportivi ricreativi), da un lato, ed il codice della navigazione, dall’altro, sussiste un rapporto di specialità. Tale principio, già affermato da Cass., sez. I, 4 marzo 1980, n. 1434, è stato poi espressamente recepito anche dal legislatore nell’art. 1, comma terzo, D.Lgs. 171/2005 (“Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative”). Successivamente, Cass., sez. III, 19 novembre 2013, n. 25902, in dialogo fruttuoso con la dottrina, ha poi evidenziato “che la navigazione da diporto rivela, rispetto all’ordinamento generale (diritto comune), un livello di specialità inferiore di quanto non sia per la navigazione propriamente detta o navigazione mercantile, in ragione della minore intensità con cui si presenta il fattore tecnico, posto alla base della specialità e dell’autonomia del diritto della navigazione. Ciò che si vuol dire è che la normativa sul diporto nautico e la relativa disciplina evidenziano caratteri meno speciali rispetto al diritto della navigazione, tali da avvicinarla – e non da allontanarla – al diritto comune”, sì che alcune norme di diritto comune, non applicabili con riferimento alla navigazione mercantile, lo divengono in relazione alla navigazione da diporto.
Sulla base di tali rilievi è stato affermato che “il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest’ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell’accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall’art. 414 c.n., secondo il quale è il danneggiato a dovere provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli; è applicabile, invece, l’art. 47 della L. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall’art. 40 del D.Lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto), in base al quale, per espresso rinvio all’art. 2054 c.c., è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli” (v. Cass., sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25771; 26 giugno 2015, n. 13224).
Dal richiamo all’art. 2054 cod. civ. deriva un’uniformità di interpretazione, tanto nel campo del navigazione da diporto, quanto in quello della circolazione stradale, ivi compresa l’evoluzione registratasi con riferimento al trasporto di cortesia, per essere la tutela del danneggiato elemento unificante delle relative discipline, risultando uguali, sia l’esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato, sia il bene giuridico, di rilevanza costituzionale, da salvaguardare, ossia la tutela della salute e della integrità fisica (v., sempre, Cass. 25902/2013 cit.).
Va peraltro ricordato che l’art. 2054 cod. civ. accorpa al suo interno quattro ipotesi di ipotesi di responsabilità (v. Cass., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620) espressione di principi di carattere generale applicabili, ricorrendo la stessa ratio, a tutti i soggetti che dalla circolazione subiscano dei danni, compresi i trasportati, quale che sia il titolo. Da ciò si è tratto che “non vi è, quindi, alcuna ragione per assegnare, nel diporto nautico, all’art. 2054, primo comma c.c. un ambito applicativo diverso da quello che gli è stato riconosciuto nella circolazione stradale” (v., ancora, Cass. 25902/2013, cit.). Conseguentemente, nel trasporto amichevole, effettuato con unità da diporto, la responsabilità del conducente (vettore amichevole o di cortesia) è retta dall’art. 2054, primo comma, cod. civ.
Si consideri, ancora, che in base all’art. 123 cod. ass. le unità da diporto dotate di motore non possono essere poste in navigazione “se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile”. Il richiamo espresso all’art. 2054 cod. civ. contenuto in tale norma deve essere letto unitamente all’art. 40 D.Lgs. 171/2005, con la conseguente previsione di una copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità verso terzi del conducente e del proprietario.
Ancora, l’art. 129, comma primo, cod. ass. dispone che “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro”. Di qui, conclusivamente è stato affermato che “anche sotto questo profilo, pertanto, l’analogia di situazioni è stata resa evidente dal legislatore che ha equiparato – prevedendo una normativa analoga – situazioni che rivestono il medesimo interesse sociale, indipendentemente dal settore di provenienza. Il microsistema giuridico dell’assicurazione obbligatoria, in questo caso, si è adeguato al macrosistema della responsabilità civile in generale” (v. Cass. 25902/2013, cit.).
Deve essere, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest’ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell’accertamento della responsabilità verso terzi, si applica l’art. 40 D.Lgs. 171/2005 in base al quale, per espresso rinvio all’art. 2054 cod. civ., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, compreso il trasportato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli“