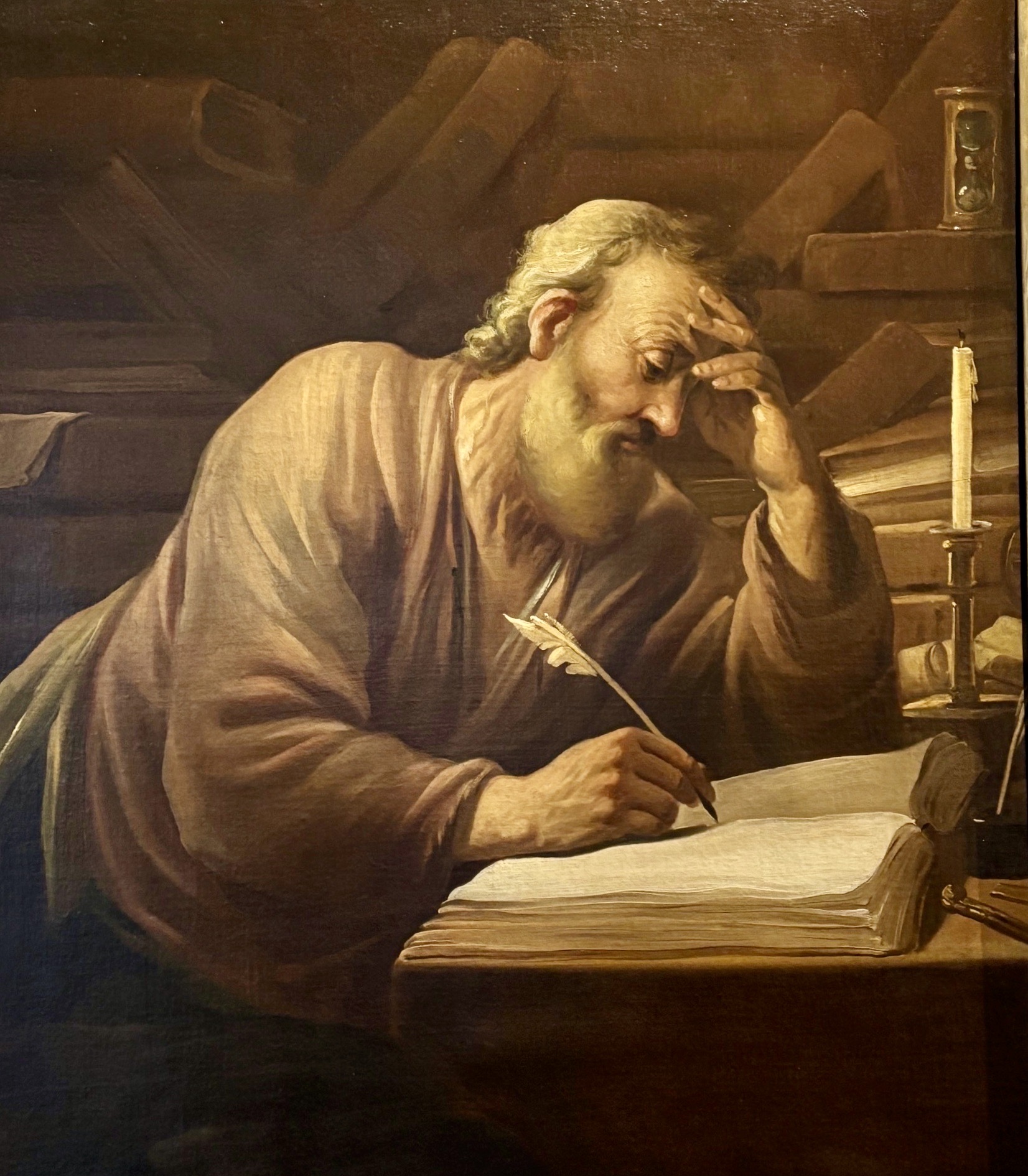Nell’ambito di un giudizio risarcitorio (per incidente stradale), il Giudice di Pace, disattendendo le risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio medico legale, procedeva ad una valutazione maggiore della lesione da quella indicata dal proprio Ausiliario. Ed infatti se quest’ultimo aveva indicato nel 2% i postumi d’invalidità permanente, il giudicante, rilevando trattarsi di “danno tabellare che, una volta accertato nella sua entità, corrisponde (anche per le sue evidenti ripercussioni in termini estetici ed esistenziali, in relazione all’età del danneggiato) ad una percentuale di danno permanente del 7%“, liquidava, in favore del danneggiato, la maggiore corrispondente somma di Euro 15.081,00. Il Tribunale riformava la precedente sentenza allineandosi all’indicazione fornita dal CTU. Impugnata la sentenza sul punto, la Corte di Cassazione (sentenza del 23 luglio 2025 n. n. 20788 – dott. Gaime Stefano Guizzi) l’accoglieva ritenendo la decisione del Tribunale sostanzialmente immotivata ed anche contraria ad una norma di diritto, qual è, evidentemente, il suddetto decreto ministeriale.
Ed invero: “in materia di liquidazione del danno alla persona, la decisione del giudice “non può trascurare di accertare se il “barème” utilizzato dall’ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato ‘ (Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2021, n. 11724, Rv. 661322-04), sicché, nella specie, il giudice d’appello avrebbe dovuto almeno adeguatamente chiarire le ragioni per le quali ha inteso disattendere le conclusioni del primo giudice, ancorché esse fossero fondate su un criterio di riconosciuta validità scientifica, recepito, per giunta, in una norma di diritto. Deve, pertanto, ribadirsi che il “barème” è “un criterio di giudizio nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico (al quale spetta precipuamente descrivere la disfunzionalità a carico del danneggiato), la cui valutazione scientifica è, del resto, secondo il principio judex peritus peritorum fatto proprio dal nostro ordinamento, sempre sindacabile dal giudice stesso in base a cognizioni tecniche personali”, tuttavia “incontrando l’esercizio di tale potere” il limite costituito dall’onere di “un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 11724 del 2021, cit.). Nella specie, in conclusione, in assenza di migliori specificazioni delle ragioni che hanno portato il giudice d’appello a disattendere il “barème” di cui al D.M. del 2 luglio 2003, ricorre, oltre ad una violazione di norma di diritto, una delle ipotesi di motivazione apparente, ovvero quella in cui la parte motiva della sentenza rechi “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1 marzo 2022, n. 6758, Rv. 664061-01)“