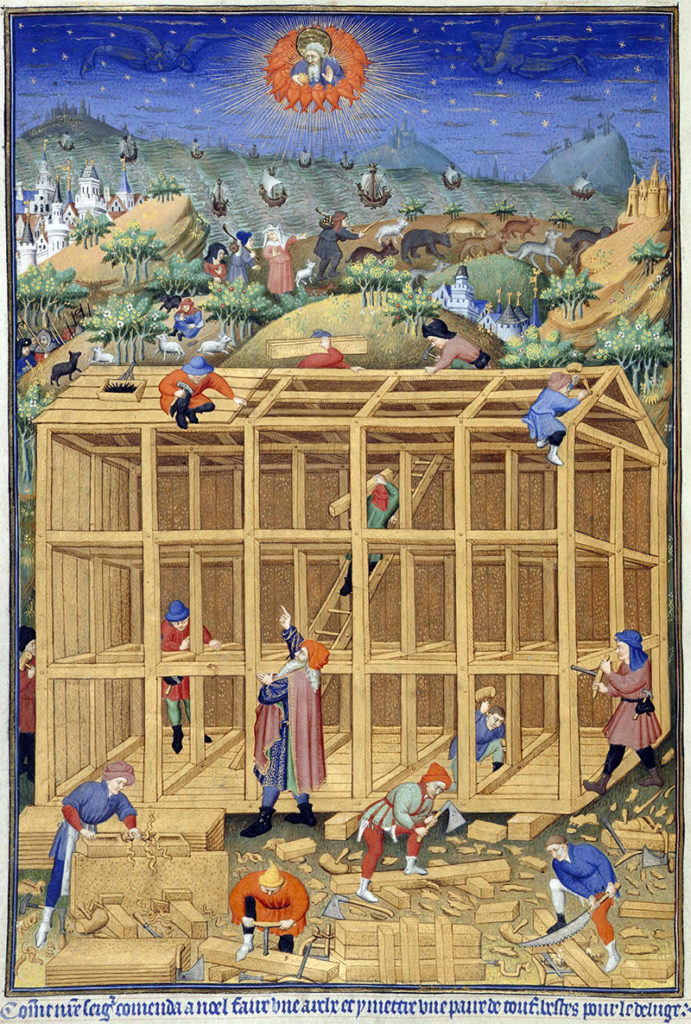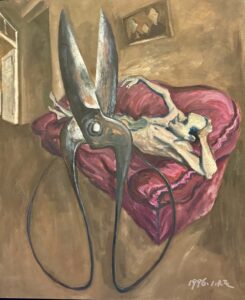In ordine al reddito da porre alla base della liquidazione del danno futuro da perdita della capacità di guadagno per un lavoratore autonomo (avvocato), la Corte territoriale aveva ritenuto che esso non potesse essere individuato nell’importo al lordo delle imposte risultante dal Modello Unico, prodotto dal danneggiato, ma nel minor importo, coincidente con il reddito netto, importo determinato previa detrazione dal fatturato, oltre che delle spese, anche della somma da versare a titolo di imposta. La sentenza è stata impugnata avanti la Corte di Cassazione rilevando che la Corte d’Appello, pur essendo consapevole dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in relazione alla portata dell’art. 137 D.Lgs. n. 209/2005, nella parte in cui disciplina l’azione risarcitoria del lavoratore autonomo, lo avrebbe scientemente disatteso, disapplicando sia la norma del codice delle assicurazioni sia il suo precedente rappresentato dall’art. 4 del decreto-legge n. 857/1976, in vigore sino al 31 dicembre 2005, agganciando la propria decisione a considerazioni di carattere metagiuridico ed assumendo indebitamente che l’interpretazione tradizionale aderente al testo legislativo non si sottrarrebbe a dubbi di costituzionalità. Il ricorrente ricorda che, al contrario, alla stregua dei principi costantemente affermati dalla Corte di cassazione, l’art. 4 del decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dalla legge di conversione n. 39 del 1977, nel disporre che, in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell’applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l’applicazione dell’imposta stessa, ma alla base imponibile di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 597 del 1973, e cioè all’importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell’imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d’acconto) ed il totale dei costi inerenti all’esercizio professionale – analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati – senza possibilità di ulteriore decurtazione dell’importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d’imposta sofferte dal professionista (viene citata, oltre a più risalenti pronunce, la sentenza n. 11759 del 2018).
La Corte di Cassazione (sentenza del 12 agosto 2025 n.23108), nel confermare la sentenza impugnata, rileva che: “non vi è dubbio che nella giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della previgente disciplina, dettata dall’art. 4 del decreto-legge n. 857 del 1976 è prevalso l’orientamento interpretativo secondo cui, con riguardo al reddito da lavoro autonomo, la norma attribuisce rilievo, non già al reddito che residua dopo l’applicazione dell’imposta ma alla base imponibile di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 597 del 1973, e quindi al maggior importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell’imposta da versare (in tal senso, oltre alla già citata Cass. n. 11759 del 2018, v. già Cass. n. 18855 del 2008 e, prima ancora, ex aliis, Cass. n. 5680 del 1996). Tuttavia, questo orientamento deve essere necessariamente rimeditato alla luce della contraria, argomentata posizione interpretativa recentemente assunta da questa stessa Corte di legittimità in relazione alla portata dell’art. 137 cod. ass. in riferimento al reddito da lavoro dipendente. Il rispetto del principio di ragionevolezza esige infatti che, nell’interpretazione della norma, si proceda necessariamente ad un coordinamento tra la posizione del lavoratore dipendente e quella del lavoratore autonomo ai fini della liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa.
L’art. 137 cod. ass. stabilisce che “nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge“. Sebbene, per il lavoro dipendente, facendo riferimento al reddito di lavoro “al lordo” delle detrazioni e delle ritenute di legge, la norma sembrerebbe aver ripreso una formulazione simile a quella originaria, quale contenuta nell’art. 4 del decreto-legge n. 857 del 1976 prima delle modifiche operate dalla legge di conversione n. 39 del 1977, che avevano eliminato il riferimento al “reddito lordo”, nondimeno questa Corte ha ritenuto che una interpretazione costituzionalmente orientata e attenta agli indici ricavabili dal sistema della responsabilità civile quale vigente nel nostro ordinamento debba portare a porre a base del calcolo del danno da perdita della capacità di guadagno il reddito al netto delle ritenute fiscali (Cass. 29/04/2025, n. 11320). In tal senso si è argomentato dal principio dell’integralità del risarcimento (o, nell’incisivo lessico utilizzato da autorevole dottrina, principio del “danno effettivo”) di cui è espressione l’art. 1223 cod. civ., il quale, se da un lato richiede che il risarcimento valga a compensare il danneggiato integralmente del danno subito, dall’altro vieta che con il risarcimento egli ottenga più di quanto abbia effettivamente perduto.
In base a questo principio, il risarcimento del danno da perdita o riduzione della capacità di guadagno deve porre il danneggiato nella stessa condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato il fatto illecito: per il lavoratore danneggiato dovrebbe essere patrimonialmente indifferente lavorare e percepire la paga, ovvero non lavorare a causa della procurata incapacità e percepire il risarcimento. Infatti, se il lavoratore non avesse patito il danno, avrebbe percepito la retribuzione ma avrebbe dovuto pagare le tasse: e siccome il risarcimento non può trasformarsi in un arricchimento per il danneggiato, esso deve essere pari al reddito che la vittima avrebbe percepito, al netto delle tasse. Diversamente, in conseguenza del sinistro la vittima percepirebbe somme superiori a quelle che avrebbe ottenuto se il danno non si fosse verificato, e per di più senza vantaggi per l’erario. Si è anche evidenziato che questo generale principio in materia di risarcimento del danno trova riscontro nella legislazione tributaria, dal momento che l’art. 6, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) esclude dall’imposizione fiscale i risarcimenti conseguiti in sostituzione di redditi a causa di invalidità permanente o di morte. Da ciò si è tratta, a contrario, la conferma che la relativa liquidazione non possa comprendere anche le somme che il danneggiato, se avesse continuato a lavorare, non avrebbe comunque percepito in quanto destinate all’erario mediante ritenuta alla fonte. Se, infatti, il reddito da porre a base del risarcimento dovesse essere quello lordo, il legislatore tributario non ne avrebbe previsto la non imponibilità. Diversamente opinando, il danneggiato verrebbe a ricevere somme destinate non a lui ma all’erario e che nemmeno successivamente egli sarebbe tenuto a versare all’effettivo creditore.
Sulla base di queste considerazioni di carattere sistematico, si è ritenuto che il disposto testuale della norma, nella parte in cui fa riferimento al reddito del lavoratore dipendente “al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge”, debba essere circoscritto nella sua portata con riferimento alle sole ritenute non fiscali (ovverosia, alle ritenute di carattere assicurativo e previdenziale) con esclusione delle ritenute tributarie. Queste ultime, infatti, concretando un prelievo fiscale per conto dell’Erario, rifluiscono nella fiscalità generale e non vi è alcun rapporto sinallagmatico individuale tra contribuente e servizi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici, dei quali beneficiano tutti coloro che ne hanno diritto, indipendentemente dalle imposte da ciascuno eventualmente pagate. Le prime invece, concretando trattenute effettuate dal datore di lavoro di somme dovute ad enti previdenziali o assicurativi, a titolo di contributi gravanti sul lavoratore, trovano il loro corrispettivo nel trattamento assicurativo e previdenziale spettante al lavoratore, la cui perdita, a causa del mancato versamento dei detti contributi cagionato dall’illecito, integra pertanto una posta di danno risarcibile. Si è dunque affermato il principio secondo il quale “L’art. 137, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato” (Cass. n. 11320 del 2025, cit.)“.
Alla luce dei principi affermati in ordine al reddito da lavoro dipendente, il Collegio afferma che: “non può non essere rimeditato il tradizionale diverso orientamento interpretativo consolidatosi in ordine alla posizione del lavoratore autonomo, dovendo necessariamente essere coordinate le due posizioni. Al riguardo, del resto, deve considerarsi che mentre, come si è detto, la formulazione dell’art. 137 cod. ass. continua, in relazione al lavoratore dipendente, ad evocare il reddito “al lordo” delle detrazioni e delle ritenute di legge, invece con riguardo al lavoratore autonomo la norma fa riferimento al “reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”. Pertanto, se, da un lato, sotto il profilo sistematico, le esigenze di compatibilità con il principio di integralità del risarcimento si pongono per i redditi da lavoro autonomo allo stesso modo che per quelli da lavoro dipendente, dall’altro lato, con riguardo al primo, l’interpretazione logico-sistematica della norma appare anche quella più in linea con il suo disposto testuale.
Ma, al di là del dato letterale e di quello sistematico, militano – nel senso di circoscrivere la base reddituale rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 137 cod. ass., al reddito al netto della somma dovuta a titolo di imposta – decisive ragioni di compatibilità a Costituzione della norma, cui doverosamente l’ermeneuta deve dare spazio in sede di esegesi costituzionalmente orientata, evidenziandosi che una diversa interpretazione risulterebbe collidente con l’art. 3 Cost., avuto riguardo, come tertium comparationis, alla generale disciplina di cui all’art. 1226 cod. civ. Mentre, infatti, il responsabile di un danno diverso da quello causato dalla circolazione stradale è tenuto a risarcire solo i pregiudizi effettivamente derivati dalla sua condotta, il responsabile di un danno causato dalla circolazione stradale sarebbe tenuto a risarcire la vittima in misura eccedente il pregiudizio effettivamente patito.
Tali esigenze valgono, ovviamente, sia per il lavoratore autonomo che per quello dipendente, non potendo ammettersi, in spregio al principio di ragionevolezza, una diversa misura del risarcimento, a parità di danno effettivo, a seconda che la vittima appartenga all’una o all’altra categoria. Può dunque ritenersi che la difformità testuale tra le due distinte protasi dell’apodosi normativa contenuta nell’art. 137 cod. ass. – ferma la necessità, in entrambi i casi, di fare riferimento al reddito al netto delle imposte – sia dovuta esclusivamente alle diverse modalità di applicazione del prelievo fiscale, dovendosi, per il lavoratore dipendente, escludere le “ritenute” tributarie e fare riferimento al “reddito al lordo delle ritenute non tributarie” e, per il lavoratore autonomo, non soggetto a “ritenute”, fare riferimento al “reddito netto dichiarato”, escluse le somme dovute a titolo di imposte. Va dunque confermato – dando seguito ad un consolidato orientamento – che, ai fini della liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ai sensi dell’art. 137 cod. ass., rileva il reddito “dichiarato” (da ultimo, in tal senso, cfr. Cass. n. 23330 del 2024). Va però precisato che, ove – come di norma avviene e salvo il riscontro degli enti preposti al relativo accertamento – l’importo del reddito dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sia comprensivo della somma da versare all’erario a titolo di imposta, questa somma deve essere detratta ai fini della detta liquidazione, dovendo farsi riferimento al reddito dichiarato al netto dell’imposta“.
La Corte in definitiva afferma il seguente principio di diritto: “L’art. 137, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore autonomo, al reddito “netto” più elevato dichiarato dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da determinarsi previa esclusione dallo stesso delle somme da versare all’Erario a titolo di imposta“.