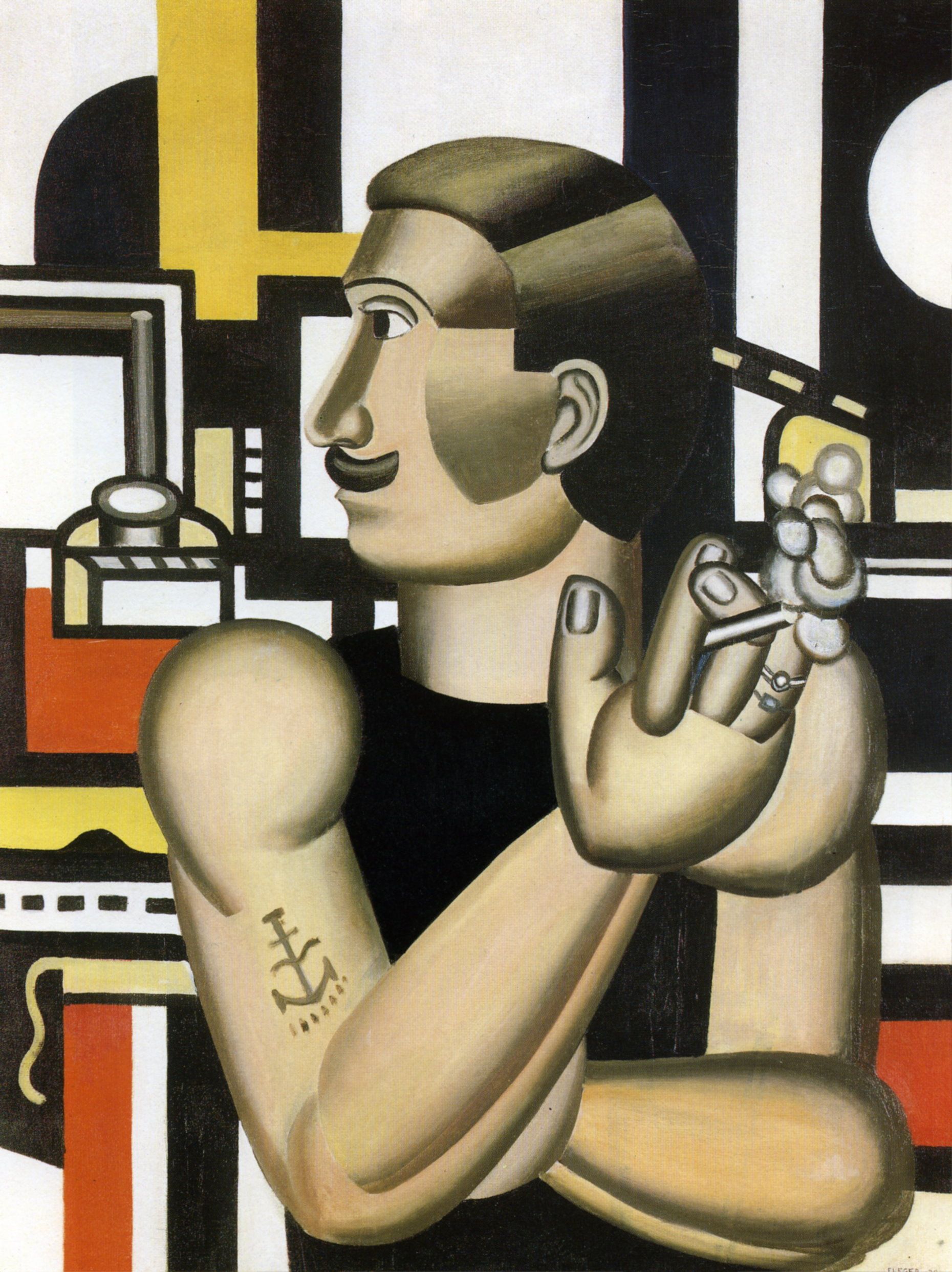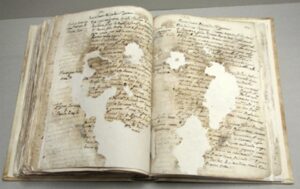Un addetto alla riparazione e sostituzione di cristalli di autoveicoli, rimaneva gravemente infortunato a seguito di un incidente stradale, assentandosi dal lavoro per diversi mesi. L’azienda, presso cui lavorava, corrispondeva al dipendente le relative prestazioni retributive, provvigionali e previdenziali, di cui poi otteneva il rimborso dal responsabile del sinistro. Lamentando però che durante la malattia si era trovata priva di un’unità lavorativa la cui alta specializzazione aveva reso di fatto impossibile provvedere alla sostituzione del dipendente, con conseguente contrazione della propria produttività e rinuncia a svariate commesse, richiedeva l’ulteriore risarcimento .
La Corte territoriale rigettava la domanda rilevando che l’insostituibilità del lavoratore dipendente e la diligenza impiegata dal datore di lavoro nel reperimento di un sostituto durante la malattia del dipendente, non erano stati provati, spettando infatti il relativo onere a carico dell’attrice. Quest’ultima ricorreva avanti la Corte di Cassazione affermando che ciò contrasterebbe con l’interpretazione degli art. 2697 e 1227 secondo comma c.c., trattandosi di eccezione in senso proprio nella quale è “il debitore a fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l’ordinaria diligenza” (Cass. civ., n. 15750 del 27 luglio 2015, Cass. civ., n. 7965 del 20.03.2023)
Per la Corte di Cassazione (sentenza dd. 23 settembre 2025 n. 25921) la censura non coglie nel segno, non sussistendo alcuna erronea inversione dell’onere della prova, ma la corretta applicazione della regola secondo la quale la dimostrazione dei fatti principali della pretesa è a carico dell’attore. Il Collegio infatti osserva correttamente: “che l’infungibilità e/o la non agevole sostituibilità della prestazione lavorativa rappresenta un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, di talché il relativo onere probatorio, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, continua a gravare sull’attore ex art. 2043 c.c. e non sul convenuto ex art. 1227,2 comma, c.c. Come è noto, con la sentenza a Sezioni Unite del 12 novembre 1988 n. 6132, questa Corte ha stabilito che: “il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)“. Ciò ha consentito al datore di lavoro del dipendente infortunato di esercitare una azione diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante, ritenuto responsabile del sinistro, unitamente a quest’ultimo (Civ. sez. III 21-10-1991 n. 11099 e n. 11100, Cass sez. III 4-11-2002n. 15399, Cass. Civ. sez. Lav. 15-09-2003 n. 13549 e Cass. civ. del 9.02.2010, n. 2844). In tale ultima decisione si legge “Nel caso del datore di lavoro, infatti, palesemente non ricorre in capo al medesimo un obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore ed il suo credito nei confronti dell’autore dell’illecito – benché non riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c. – trova non di meno la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva.
Il datore di lavoro, tuttavia, potrà richiedere unicamente il risarcimento dei danni immediati e diretti con specifico riferimento agli eventuali oneri contributivi e retributivi che il datore sarà tenuto comunque a versare. In assenza di prestazione lavorativa, quindi, potrà esigere dalla Compagnia assicuratrice la quota di retribuzione differita maturata nel periodo di assenza (la Tredicesima, la Quattordicesima, la Gratifica Natalizia, il Premio di Produzione, il TFR etc.) nonché le ferie non godute e comunque maturate in tale periodo. L’istituto della tutela aquiliana del credito, che costituisce oramai un principio giurisprudenziale consolidato, nel tempo, si è via via ampliato sino ad arrivare a riconoscere la tutela della lesione del diritto di credito del terzo anche quando non sussista il requisito della “insostituibilità” dell’obbligato. Questo (nuovo) orientamento giurisprudenziale ha, di fatto, permesso un più ampio riconoscimento con la conseguenza che sempre più, anche nelle cause di responsabilità medica, si vede un ulteriore soggetto che agisce o interviene nel giudizio per lamentare la “propria” lesione del credito. Va, infatti, riconosciuto il diritto del datore di lavoro al risarcimento dei danni direttamente cagionatigli dalla privazione delle energie lavorative del dipendente rimasto leso a causa di un errore costituente fatto illecito, posto che l’assenza del lavoratore priva l’imprenditore delle forze che quel prestatore, in quel certo periodo, sarebbe stato vincolato a prestare esclusivamente in favore dell’azienda alla quale è legato dal rapporto di lavoro.
L’impossibilità della prestazione lavorativa determina un pregiudizio irreparabile, perché il datore di lavoro non può evitare di pagare le quote di retribuzione a suo carico, di cercare un sostituto e pagargli il suo corrispettivo per lo svolgimento di quelle mansioni, di subire dei contraccolpi economici alla sua attività nel caso in cui il dipendente sia in concreto insostituibile. Siffatti pregiudizi sono stati causati dal responsabile del sinistro, da cui è scaturita la malattia del dipendente che gli ha impedito di svolgere la sua attività. Oltre ciò, come nel caso di specie, il datore di lavoro danneggiato può allegare la “insostituibilità” del lavoratore, sulla base della particolare specializzazione dello stesso e dell’assetto organizzativo dell’impresa, tale da non prevedere una duplicazione di competenze anche specialistiche. Dovrà altresì dimostrare, oltre al nesso di causalità materiale tra la condotta del terzo ed il danno alla produzione, anche la circostanza specifica di non avere potuto sostituire il dipendente, nonostante i reiterati tentativi espletati e di avere subito una perdita economica direttamente riconducibile all’interruzione dell’attività produttiva“.