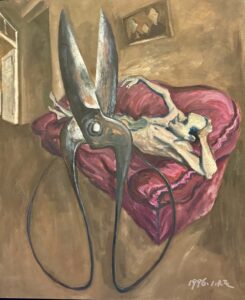La Corte di Appello di Genova riteneva sussistente una responsabilità dei medici negli interventi successivi e nel monitoraggio del funzionamento dell’apparecchio, riconoscendo un danno biologico al bambino, prima gravemente ferito e poi deceduto, e dunque un diritto al risarcimento trasmissibile agli eredi, ma negando il diritto dei congiunti ad un risarcimento del danno iure proprio, sulla base del seguente ragionamento: i genitori hanno stipulato il contratto solo nell’interesse del minore, non in quello proprio, e dunque non possono invocare l’inadempimento contrattuale, possono soltanto agire per far valere una responsabilità extracontrattuale, ma in questo caso l’onere di provare la colpa è a loro carico, e tale onere non è stato assolto. Tale ratio è stata contestata dai ricorrenti, assumendo che , nella stipula del contratto con la struttura sanitaria, i genitori hanno fatto valere un diritto proprio alla salute, che giustifica l’azione contrattuale in ragione di una interpretazione estensiva delle regole sulla efficacia protettiva del contratto, o meglio sulla efficacia verso terzi. I ricorrenti mirano a dimostrare che la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, invocata dai giudici di merito, per escludere l’azione da contratto a favore dei genitori, va intesa, in conformità con i principi costituzionali, come riguardante anche entrambi i genitori: ossia il contratto con effetti protettivi verso terzi andrebbe inteso nel senso che tale contratto protegge anche i genitori di un bambino leso dalla condotta dei medici e non solo il bambino medesimo.
La Corte di Cassazione (sentenza del 16 settembre 2025 n. 25404 – Rel. dott. Giuseppe Cricenti) accoglie il motivo, anche se con una diversa motivo, rilevando che: “il modo in cui il motivo e formulato e stato imposto dall’equivoco in cui sono incorsi i giudici di appello, che hanno richiamato una figura, quella del contratto con effetti protettivi verso terzi, per una fattispecie diversa, estranea cioè a quella figura. I giudici di merito, a dimostrazione della incomprensione della figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, e del suo ambito di applicazione, scrivono che: ” La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il rapporto contrattuale è intercorso soltanto tra la struttura sanitaria e il paziente, non essendo invece configurabile un analogo rapporto tra la struttura sanitaria e i congiunti del paziente ” (p. 16), per poi concludere che questi ultimi hanno solo l’azione extracontrattuale. Ora, è pacifico, e risulta anche dalla stessa sentenza, che a stipulare il contratto sono stati i genitori del bambino, e dunque e pacifico che il contratto non può essere intercorso, come i giudici di merito assumono, tra la struttura sanitaria ed il paziente, il quale in quel momento aveva nove mesi.
I genitori erano dunque formalmente parti del contratto, ossia hanno stipulato loro il contratto che aveva ad oggetto la cura del figlio. Per poterli ritenere “estranei” al contratto, ossia per potere dire che, nonostante siano parti, non hanno l’azione contrattuale, occorre dire (ed implicitamente la corte di merito lo fa, nel momento in cui dice che i congiunti vantano, si, un diritto iure proprio, ma possono farlo valere solo in via extracontrattuale), che i genitori quando stipulano un contratto per la cura del figlio neonato fanno valere solo l’interesse di quest’ultimo, e non già un proprio personale interesse. Ossia, occorre dire che nell’affidare il figlio alle cure dei medici, e dunque nello stipulare il contratto con la struttura, i genitori non fanno valere anche un proprio interesse a che il figlio sia curato, ma agiscono soltanto in rappresentanza di quest’ultimo e solo nel di lui interesse.
Questa affermazione, per certi versi, è in astratto anche ammissibile, ma occorre motivare perché i genitori non hanno dedotto in contratto anche un loro interesse. In altri termini, i giudici di merito riconoscono che i genitori hanno un diritto proprio, autonomo “ad essere risarciti dalla struttura sanitaria per i danni che essi hanno direttamente subito” (p. 16), ma escludono che tale diritto sia stato dedotto in contratto. Non è dato capire perché: nel senso che non c’è alcun argomento in base al quale si giustifica l’affermazione che, seppure i genitori hanno un diritto proprio alla salute del figlio, o meglio, a che i medici non causino danni alla salute del figlio, tuttavia essi non possono dedurre tale interesse in un contratto. Piuttosto è esattamente il contrario. Se è vero che i genitori stipulano nell’interesse del figlio, è altrettanto verso che stipulano altresì nel loro interesse, ed è altrettanto vero che l’inadempimento del medico, lede, si, la salute del destinatario della prestazione ma anche un interesse dello stipulante, ossia dei genitori, interesse che è protetto direttamente dal contratto, e non per riflesso. Con la conseguenza che il richiamo alla giurisprudenza sugli effetti protettivi del contratto è del tutto fuori luogo. Quella giurisprudenza postula che a rivendicare l’azione contrattuale sia un soggetto che non è stato parte del contratto, e che dunque chiede che gli effetti di quest’ultimo vengano estesi anche a lui. Se invece ad invocare l’azione contrattuale, ossia a far valere l’inadempimento, è un soggetto che è formalmente parte del contratto, ossia che ha stipulato, non si fa questione di effetti protettivi del contratto, ossia non si fa questione del se gli effetti del contratto, che normalmente riguardano le parti, possano estendersi al terzo.
Ad esempio, nel contratto stipulato solo dalla gestante con il medico, il marito non è parte, poiché solo la gestante ha concluso l’accordo: in quel caso si fa questione se il marito, che si ripete, non è formalmente parte del contratto e dunque non ha stipulato, possa agire anche egli con l’azione contrattuale (v. Cass. 17113 / 2024). A leggere attentamente le decisioni di questa Corte sugli effetti protettivi del contratto verso terzi, questo significato non può sfuggire: si tratta di casi in cui pretende di esercitare l’azione contrattuale un congiunto che non è stato parte del contratto, che non ha stipulato direttamente: come in Cass. 146157/2020, dove il contratto era stato stipulato direttamente dal paziente poi deceduto per infezione ospedaliera, e dove è stato negato ai congiunti, che non erano parti del contratto, l’azione contrattuale; come in Cass. 14258 del 2020, espressamente citata dalla sentenza impugnata (p.16), nella quale si dice chiaramente che il rapporto contrattuale è intercorso solo tra “la menzionata struttura ed il ricoverato” e dove dunque i congiunti di quest’ultimo non erano parti del contratto, ma pretendevano di avere comunque l’azione contrattuale. Del resto, a voler fare affidamento sulla giurisprudenza in tema di effetti contrattuali verso terzi, si ricava il contrario: quella giurisprudenza non nega l’azione contrattuale alla madre gestante, né ricorre all’argomento che costei agisce solo in rappresentanza del nascituro. Che la gestante abbia azione contrattuale è dato per scontato, proprio perché è lei a stipulare il contratto. Semmai si discute sull’azione contrattuale del marito, qualora non sia parte del contratto.
In conclusione, nella fattispecie, è pacifico che il contratto è stato stipulato dai genitori. Per contro, non v’è alcuna ragione, perlomeno la corte di merito non ne adduce alcuna, per ritenere che i genitori affidando il bambino alle cure dell’ospedale, non abbiano voluto far valere anche un diritto proprio, ossia che abbiano agito solo per conto e nell’interesse del minore. Ed anzi, una tale ricostruzione è contraria agli scopi del contratto che i genitori stipulano con la struttura per la cura del figlio. Lo è in quanto postula che, pur avendo i genitori un interesse proprio ed autonomo, a che il figlio venga curato, e dunque alla corretta esecuzione della prestazione medica, non possono però dedurlo nel contratto, ma devono farlo valere con l’azione aquiliana: il che contrasta con l’ovvia constatazione che il luogo più adeguato per far valere quell’interesse è proprio il contratto. Se si ammette che i genitori hanno un interesse proprio, ossia distinto da quello del minore, alla cura di quest’ultimo, allora è proprio il contratto con il medico, cui quella cura è affidata, il luogo in cui l’interesse si fa valere. È del tutto estraneo alla logica della causa dei contratti che costoro, che hanno interesse proprio ad una prestazione verso un terzo, e che stipulano il contratto perché quella prestazione venga eseguita, non possano dedurre il loro interesse proprio in quel contratto, che è invece il luogo destinato a farlo valere.
La tesi della corte di merito, dunque, fraintende la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, applicandola anche a casi in cui chi agisce in base al contratto non è terzo, ma è, per l’appunto, parte di quel contratto: la conseguenza di tale fraintendimento è stata che, essendo la domanda dei ricorrenti volta a far valere una responsabilità extracontrattuale e non già contrattuale, l’onere della prova era diverso, e gravava, quanto a tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, sugli attori. Invece, la domanda va qualificata come di risarcimento da inadempimento contrattuale, con conseguente diversa distribuzione degli oneri probatori“