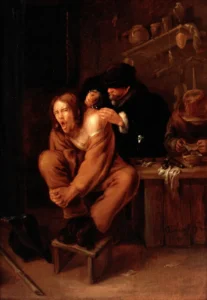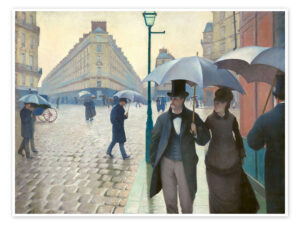La Corte di Cassazione (sentenza del 31 ottobre 2025 n. 28839) rileva che le censure poste al base del motivo di ricorso in esame sono fondate su un assunto di diritto erroneo , ossia quello di ritenere che, ai sensi dell’art. 2052 c.c., dei danni causati dagli animali risponde chi ha, in concreto, la temporanea “custodia” dell’animale, in qualche modo assimilando tale fattispecie normativa a quella dell’art. 2051 c.c., relativo alle cose. Il Collegio chiarisce invece che: “al contrario, la fattispecie normativa speciale di imputazione della responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c., non è affatto costruita sulla nozione di “custodia”, bensì su quella di “utilizzazione”, ovvero – dovrebbe forse dirsi, più precisamente – di “sfruttamento economico o funzionale”: risponde dei danni chi utilizza l’animale per trarne una propria utilità. Del resto, lo stesso art. 2052 c.c. esclude espressamente che abbia rilievo, ai fini della responsabilità, il fatto che l’utilizzatore dell’animale ne abbia la custodia o meno. In altri termini, dei danni causati dagli animali risponde, alternativamente, il proprietario, ovvero il soggetto che si serve dell’animale per soddisfare un proprio interesse, non il suo custode, in quanto tale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione per cui “chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso, trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell’animale nell’interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010: in questa decisione è stata esclusa la responsabilità di un militare che aveva subito danni a causa della condotta di un cavallo che montava per servizio e che, quindi, era evidentemente nella sua custodia di fatto; nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di questa stessa Corte sulla responsabilità del maneggio per i danni causati dai cavalli affidati ai cavalieri che li noleggiano, fondata sul principio per cui ci si può servire di un animale anche tramite terzi, cui l’animale è affidato e, in tal caso, la responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. grava comunque sul soggetto che si serve dell’animale tramite il terzo, e non sul terzo affidatario e, cioè, custode temporaneo dello stesso; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 979 del 21/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 14743 del 17/10/2002; Sez. 3, Sentenza n. 12025 del 12/09/2000; Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998)“.
È, quindi, evidente che: “la stessa prospettazione del ricorrente, secondo cui il cane responsabile del danno, pacificamente di sua proprietà, avrebbe dovuto ritenersi nella “custodia” del suo dipendente, quale custode della proprietà dove era tenuto l’animale, in quanto egli era spesso a lungo assente da detta proprietà e il Ne.Fa. si occupava, pertanto, del cane e dei suoi bisogni, non è sufficiente, già in diritto ancor prima che in fatto, ad escludere la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2052 c.c., non avendo alcun rilievo la effettiva “custodia” dell’animale e non essendo, d’altronde, neanche stata adeguatamente allegata, prima ancora che provata, una situazione tale da configurare una utilizzazione dell’animale per la soddisfazione di un interesse proprio. Quello che pare emergere chiaramente dagli atti di causa è che il cane del Ga.Gi. era utilizzato nella sua proprietà (non ha rilievo stabilire se per fini di difesa o di compagnia) e, pertanto, esso era affidato al custode di tale proprietà, affinché questi lo accudisse, ma comunque per soddisfare un interesse proprio del Ga.Gi. e non certo un interesse del suo dipendente. La Corte d’Appello solo apparentemente sembra avere assunto a fondamento della sua decisione il principio per cui avrebbe rilievo, ai fini della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., se il cane era nella “custodia” del Ne.Fa. o meno e, in tale ottica, abbia escluso proprio tale eventualità in fatto. In realtà l’errore di diritto, nella sentenza impugnata, è solo apparente perché la Corte d’Appello, in definitiva, nel decidere sui motivi di gravame, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, in cui viene enunciato espressamente quanto segue: “nel caso di specie, non soltanto non è in alcun modo stato provato che il Ga.Gi. abbia incaricato il Ne.Fa. di custodire il cane, in quanto custode della villa – non potendo in tal senso ritenersi sufficiente la mera circostanza che il proprietario abbia lasciato l’animale nella proprietà affidata al custode – ma in ogni caso si sarebbe comunque trattato di una custodia nell’interesse del proprietario, priva di potere di autonoma gestione dell’animale per un proprio interesse, che sola può far scattare la liberazione del proprietario dalla responsabilità“. Dunque, la Corte d’Appello, laddove afferma che non “risulta provato che il Ga.Gi. abbia potuto avere periodi di assenza dalla propria villa, tanto lunghi, da poter sostenere che il “pastore tedesco” fosse oramai nell’esclusivo rapporto di fatto con il dipendente, tanto da ingenerare la costante presenza di un rapporto di custodia, dal quale far discendere le responsabilità di cui si discute” ha, implicitamente, ma inequivocabilmente, affermato che non è stata raggiunta la prova della sussistenza, in capo al Ne.Fa., di un “potere di autonoma gestione dell’animale per un proprio interesse“.
Il motivo di ricorso in esame dunque: “per un verso, risulta manifestamente infondato in diritto (e, come tale, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.), in quanto contesta la decisione sulla base di un assunto giuridico erroneo e, cioè, che avrebbe rilievo il rapporto di custodia di fatto dell’animale (più precisamente, avrebbe rilievo chi sia il soggetto nella cui “sfera di controllo” si trova l’animale, ovvero chi abbia la “materiale disponibilità” dello stesso) e non l’interesse che la sua utilizzazione è diretta a soddisfare; per altro verso, è inammissibile: b1) sia perché non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, più sopra chiarita; b2) sia perché si risolve in una sostanziale contestazione della valutazione delle prove in ordine all’accertamento di fatto sull’individuazione del suddetto interesse, che la Corte d’Appello ha accertato essere esclusivamente quello del proprietario del cane, e non quello del custode della proprietà dove veniva tenuto l’animale, indipendentemente dal fatto che fosse proprio il custode dell’immobile a soddisfare i bisogni di quest’ultimo, in assenza del proprietario“.