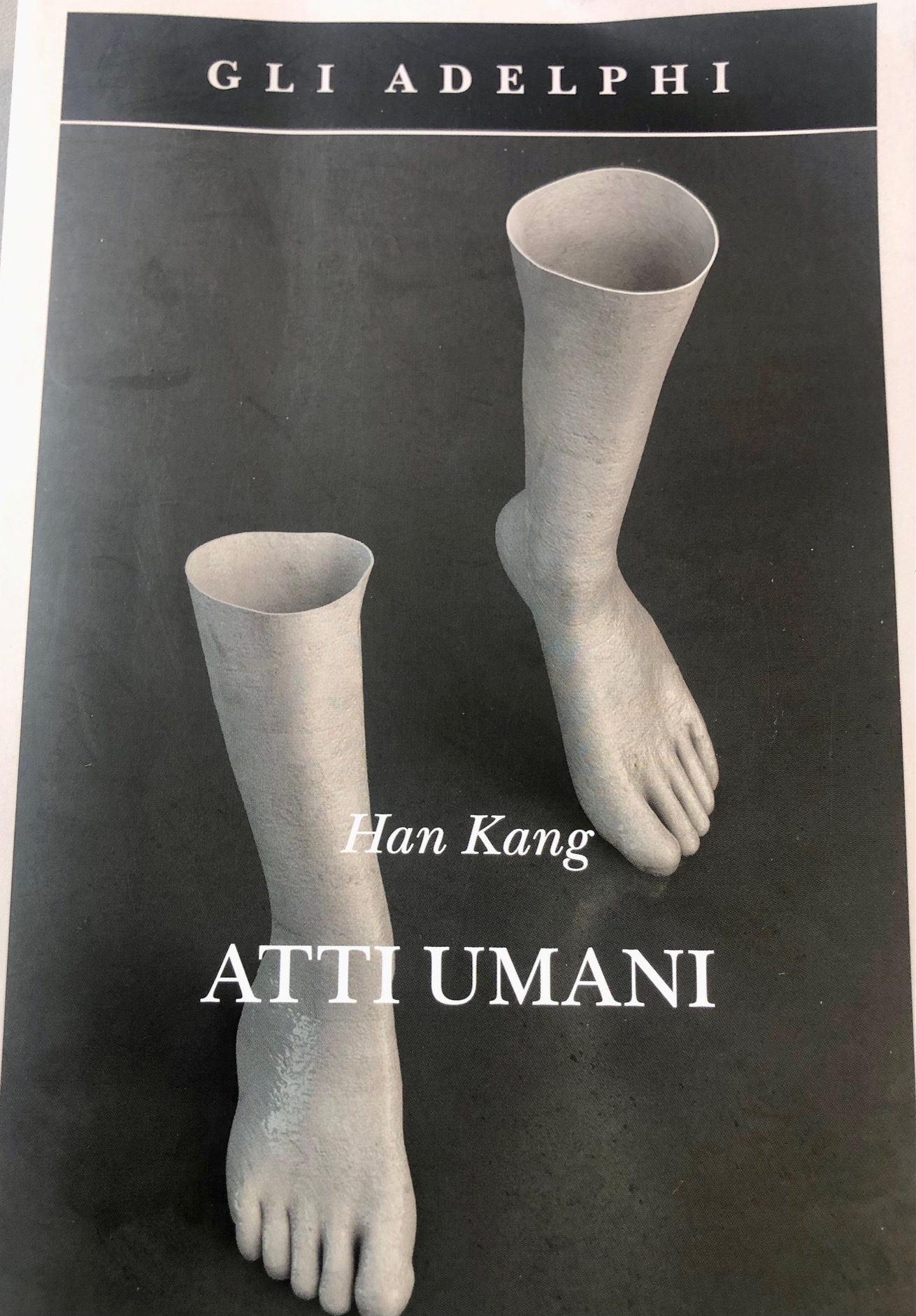Han Kang, Premio Nobel 2024, decrive con il suo stile preciso, delicato, quasi a voler glissare ogni forzatura ad effetto, e per questo scarnificato fino all’essenziale, il dramma della morte di un giovane figlio. Creando qualcosa di sconvolgente ed insopportabile, proprio come il dolore, vissuto ogni giorno.
“Ti ho seppellito con le mie stesse mani. Ti ho tolto la giacca e i pantaloni azzurri della tuta da ginnastica e ti ho messo una camicia bianca e la divisa invernale scura della scuola. Ti ho stretto per bene la cintura e ti ho infilato dei calzini grigi puliti. Quando ti hanno deposto in una bara di compensato e l’hanno caricata sul camion della spazzatura, ho voluto viaggiare davanti per vegliare su di te. Non avevo la più pallida idea di dove fosse diretto il camion. Ero troppo impegnata a fissare dietro, dove c’eri tu.
Quelle centinaia di persone vestite di scuro sembravano formiche che portassero bare su per una collinetta sabbiosa. La mia memoria è confusa, ma ricordo i tuoi fratelli in piedi, con le lacrime che scorrevano sulle guance e le labbra serrate. E le parole che mi disse tuo padre prima di morire. Era rimasto sconcertato quando, invece di piangere come tutti gli altri, avevo preso una manciata di erba dal mucchio di terra spalata per la fossa e l’avevo inghiottita. L’avevo inghiottita, poi ero crollata al suolo e l’avevo vomitata, e dopo averla rigettata tutta ne avevo arraffato un altro pugno e me l’ero ficcato in bocca. Bada bene, io di tutto questo non ricordo niente“.
“Il filo della vita è resistente come un tendine di bue, così, anche dopo che ti persi, dovetti andare avanti. Dovetti costringermi a mangiare, lavorare, a ingoiare ogni nuovo giorno come un boccone di riso freddo, anche si mi strozzava in gola“