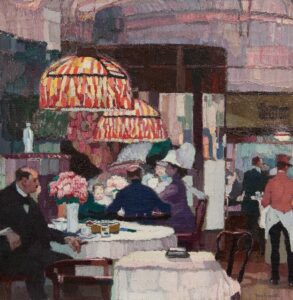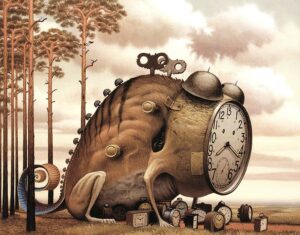La Corte di Cassazione (sentenza del 30 luglio 2025 n.21896 – dott. Stefania Tassone) riepiloga i principi oggi esistenti in ordine alla cooperazione colposa che si istaura tra il conducente ed il trasportato.
Rammenta in primo luogo l’ipotesi di circolazione su ciclomotore, costruito ed abilitato per il trasporto di una persona sola, ed invece circolante con a bordo più persone, specificando che: “qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell’art. 170 C.d.S.), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento”; (v. Cass., 22 maggio 2006 n. 18974: v. anche Cass., 13/05/2011, n. 10526, secondo cui “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato”). In casi del genere (connotati dal fatto che la vittima del sinistro si era fatta trasportare su un mezzo idoneo al trasporto di una sola persona, con l’ovvia conseguenza che il trasporto di uno o più passeggeri può ridurne la capacità di manovra e la sicurezza di esercizio), questa Suprema Corte è dunque pervenuta a ritenere configurabile una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa con l’accettazione dei relativi rischi, oltre la soglia del cd. “rischio consentito”, con la conseguente piena applicazione dell’art. 1227 cod. civ. (v. anche Cass., 14/03/2017, n. 6481)“.
Analoghe considerazioni vengono operate per il concorso di colpa del passeggero di un autoveicolo che non abbia allacciato le cinture di sicurezza, a mente del consolidato principio per cui: “qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest’ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (Cass., 10/06/2020, n. 11095; Cass., 27/03/2019, n. 8443; v. anche Cass., 04/09/2024, n. 23804)“.
Infine viene presa in considerazione l’ipotesi di alterazione dello stato psicofisico del conducente alla guida del veicolo sul quale è trasportato altro passeggero. Il tema della tutela del terzo trasportato è stato specificamente affrontato dalla normativa e dalla giurisprudenza unionale, alla luce della quale: “questa Corte ha già affermato, ex art. 363, comma 1, cod. proc. civ., che “L’art. 1227, comma 1, cod. civ., interpretato in senso coerente con l’art. 13 della Direttiva 2009/103/CE – che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti – non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza, e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore” (Cass., 17/09/2024, n. 24920). Il principio richiamato va in questa sede ribadito. Al riguardo, va ricordato che la materia dell’assicurazione r.c.a. è materia armonizzata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009. Il XXIII Considerando di tale Direttiva ricorda che è obiettivo del legislatore comunitario includere tutte le persone trasportate nei benefìci assicurativi (salvo, ovviamente, il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illegale), e che questo obiettivo “verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell’incidente”. Il Considerando XXIII aggiunge inoltre che “un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente“, e che “l’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti dell’alcol… non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici“. Resta salva, però, la responsabilità dei passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza “secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico“.
Coerentemente con tali previsioni, l’art. 13, ultimo comma, della Direttiva 2009/103 stabilisce che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero”. Il rapporto tra il Considerando XIII e l’art. 13 della citata direttiva è stato chiarito nella sentenza 30.6.2005, Candolin c. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, in causa C-537/03, con cui la Corte di Giustizia Ue ha affermato: 1) che il diritto comunitario in tema di assicurazione della r.c.a. sarebbe “privato del suo effetto utile” in presenza d’una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento – ovvero lo limitasse in misura sproporzionata – “in base a criteri generali ed astratti” (par. 29); 2) che il diritto comunitario consente invece agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato “in base ad una valutazione caso per caso” di circostanze eccezionali (par. 30). Ne deriva dunque (cfr. Cass., 17/09/2024, n. 24920, cit.) che mentre contrasterebbe con l’art. 13 Direttiva 2009/103 una norma di diritto interno che escludesse o limitasse ipso facto il diritto al risarcimento del passeggero, per il solo fatto di avere preso posto a bordo d’un veicolo condotto da persona ubriaca, non viola per contro il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in linea generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, se la condotta della vittima possa o meno ritenersi colposamente concorrente alla produzione del danno.
L’applicazione della sentenza Candolin comporta, per l’effetto, che: a) l’eventuale concorso colposo del passeggero alla concausazione del sinistro andrà accertato con giudizio sintetico a posteriori, e non con giudizio analitico a priori, per cui si dovranno vagliare, caso per caso, le condizioni della vittima e quelle del conducente; l’entità del tasso alcolemico; le circostanze di tempo e di luogo; la prevedibilità del rischio, con onere della prova a carico della parte che solleva l’eccezione, dato che la cooperazione colposa della vittima è fatto impeditivo od estintivo della pretesa attorea, per cui il fatto costitutivo della relativa eccezione va dimostrato da chi la solleva; b) l’eventuale concorso colposo di chi si lasci trasportare in automobile da un soggetto in stato di ebbrezza, fondandosi su accertamenti di fatto, è riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.
In piena conformità ai principi unionali, qui ribaditi sulla scorta di Cass., 24920/2024, si era del resto già espressa Cass., n. 1386/2023, la quale – nel richiamare Cass., 26/05/2014, n. 11698, il cui insegnamento nomofilattico già era nel senso di preservare la rilevanza dell’esposizione volontaria al rischio, ben correlandola, come chiave interpretativa dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. ed all’obbligo di responsabilità dei propri atti in esso insito – ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l’effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l’assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell’art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio – oltre il normale rischio consentito -, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227, comma primo, cod. civ. Nella specie, in applicazione dell’anzidetto principio, questa Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un veicolo guidato da un conducente sotto effetto di cocaina, nella misura quasi simbolica del 10%, senza escludere in alcun modo la copertura assicurativa“.
Nella sentenza indicata, la Corte passa poi ad esaminare se nel caso di specie la corte territoriale si sia conformata ai summenzionati principi di diritto, anche di fonte sovranazionale, affermando che: “dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale:- ha richiamato, in jure, il principio per cui “L’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (v. tra le tante Cass., 26/05/2014, n. 11698, che espressamente richiama la sentenza Candolin del 2005); – ha confermato, sotto il profilo fattuale, quanto accertato dal primo giudice, e cioè che Bo.Na. aveva accettato di farsi trasportare sull’autovettura di Bo.Ma. che si trovava in stato di ebbrezza; – ha affrontato la questione se Bo.Na. fosse consapevole o comunque potesse rendersi consapevole della ubriachezza del conducente dell’automobile e, sotto tale profilo, ha rilevato che anch’egli, la sera del sinistro, aveva abusato di bevande alcoliche unitamente al conducente Bo.Ma., e che tale situazione di ubriachezza, volontaria o colposa, non priva di rilievo gli effetti di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ., né il fatto che il danneggiato si sia esposto ad un rischio oggettivamente elevato e superiore alla soglia del cd. “rischio consentito” – è pervenuta pertanto a riconoscere la cooperazione colposa del danneggiato ex art. 1227 cod. civ., peraltro riducendone la misura al 30%, in riforma della sentenza di prime cure“.
Orbene, la motivazione resa dalla corte territoriale è ineccepibile, e resiste al sindacato di legittimità, in quanto svolta in piena conformità ai principi di diritto più sopra menzionati. Giova ancora rilevare che la corte di merito ha scrupolosamente applicato gli insegnamenti di cui alla già citata Cass., 26/05/2014, n. 11698, secondo cui, ai fini di individuare correttamente l’evento dannoso, in relazione al quale si pone la questione del concorso di colpa del soggetto danneggiato, occorre avere riguardo non all’incidente stradale in sé considerato, quanto piuttosto alla intera serie causale, all’interno della quale occorre individuare l’evento dannoso subito dalla vittima. L’evento dannoso per il danneggiato, invero, non si identifica esclusivamente con il segmento causale attinente al momento cinematico dei fatti ovvero all’incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente; occorre prendere in considerazione la “lesione del bene giudico tutelato”, e quindi nel caso di specie la morte del trasportato (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile). Orbene, tale evento dannoso non si sarebbe verificato se non si fossero realizzati dei diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato l’auto rispettando le regole del codice della strada e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire in macchina, ben conoscendo o ben potendo conoscere, avendo anch’egli abusato di bevande alcoliche quella stessa sera, insieme ed al pari del conducente, lo stato di ebbrezza in cui versava il medesimo. È dunque possibile affermare, diversamente da quanto sostenuto nell’unico motivo di ricorso, che è proprio il comportamento del trasportato che si pone all’inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui con l’evento dannoso più gravoso, la morte: il trasportato – del quale è stato rilevato un tasso alcolemico analogo a quello riscontrato sul conducente, circostanza questa che riconduce l’assunzione dell’alcol ad un momento di comune consapevolezza ed accettazione del rischio fra vittima e conducente – pur accorgendosi o potendosi accorgere dello stato di ebbrezza del conducente dell’auto – si è tuttavia esposto volontariamente ad un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull’auto e non ne ha impedito affatto la circolazione, pericolosa anzitutto per sé oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale. Per questo, i danni conseguenza che in base alle regole generali della r.c. auto dovrebbero gravare sul proprietario del veicolo (nel caso di specie anche conducente) e sulla sua compagnia assicurativa devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall’apporto causale del danneggiato stesso, e in quella misura devono rimanere a suo carico, come è appunto stato correttamente affermato dalla corte territoriale. Sempre correttamente, la corte di merito, dopo aver esaminato le circostanze dell’occorso sinistro e delle sue mortali conseguenze, ha comunque riconosciuto, sul punto anche riformando parzialmente la sentenza di prime cure, il diritto del trasportato (rectius, dei suoi eredi) al risarcimento del danno: mentre la misura della ripartizione della colpa tra il responsabile civile ed il danneggiato a cui è addebitata la cooperazione colposa è oggetto di un giudizio in fatto, non rinnovabile in questa sede di legittimità, nel caso di specie il giudice di merito ha applicato l’art. 1227, comma primo, cod. civ. conformemente ai precetti del diritto unionale, e dunque non al fine di escludere o limitare in maniera sproporzionata il risarcimento del danno conseguente al sinistro, bensì al fine di liquidarlo nella proporzionata relazione con le circostanze del caso concreto, senza affatto escludere la copertura assicurativa